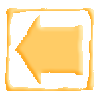
ALIA 2005
Fantasmi di carta1
di Danilo Arona
 Sarà un caso che nell'anno in cui il mercato italiano pare riconfermare la scoperta, con l'arrivo del secondo romanzo di Suzuki Kôji Spiral, delle storie nipponiche di spettri, un cospicuo spazio di Alia sia proprio dedicato a un gruppo di autori che sull'inquietante mondo degli ectoplasmi con occhi a mandorla vuole capitalizzare in modo intelligente e sinceramente perturbante? Scontata la risposta, non è un caso, perché – già lo enunciavamo lo scorso anno – l'Oriente fantastico è più che mai di tendenza e poco importa se il grande successo multimediatico di Ring (film, libro e comic) si porti dietro un po' di tutto (lo stesso Spiral è meno amabile del sequel alternativo, più intrigante e meno pedante, predisposto dal regista Nakata e dallo sceneggiatore Takahashi Hiroshi nel film Ring 2), perché il mondo dei kaidan è veramente unico e Alia è qui, anche, per dimostrarlo. La sua unicità è infatti, per paradosso, la sua estrema versatilità: nel senso che ogni autore sembra perseguire una via del tutto esclusiva, senza che sia visibile una sola coordinata in comune con un proprio affine o «vicino di casa». Prendete per esempio Asagure Mitsufumi (L'uomo con il capello e Oyakushisama), il cui senso antiretorico e il minimalismo surreale riescono a relegare in secondo piano il dato che «comunque qui di fantasmi si parla», giungendo a fornirci con il secondo titolo un racconto destrutturato temporalmente da leggersi più volte, seguendo le istruzioni dell'autore sulla disposizione funzionale dei singoli capitoli. Prendete lui e paragonatelo, se vi fosse possibile, a quella sorta di Richard Matheson orientale che è Hayami Yûji, presente con tre titoli, uno più efficace dell'altro, dove le peculiarità del genere sono sì riconoscibili per quanto originalmente declinate: da Notte sul vagone letto, un inconsueto e raggelante horror express la cui soluzione ricorda non poco – ma con assoluta causalità – la bellissima cornice nonché il finale de Le cinque chiavi del terrore, film di Freddie Francis del 1964, passando attraverso il surreale Fumo sottile, in cui scopriamo che è possibile sposarsi con una zanzara e per fortuna restarne in fretta vedovi (non mancando di avere provato quel brivido di alterità che ti coglieva dopo avere letto La mosca di George Langelaan), e giungere a un autentico incubo metropolitano, Rumore di passi, che dimostra che certe paure sono del tutto analoghe in ogni parte del mondo. Nel racconto di Iino Fumihiko Colpo di fulmine invece il terrore cambia talmente registro che sembra aleggiarvi quel surrealismo caro al Gruppo Panico degli Arrabal e dei Jodorowski: da un punto di vista quanto mai particolare (un io narrante che è il fantasma di un suicida – ma lo sapremo soltanto verso la fine…), quello di chi s'innamora a prima vista di una ragazza molto bella che sta entrando in un albergo assai particolare, scopriremo tra autentici tocchi/schizzi di splatter intollerabile che la poveretta andrà a subire una sorte terrificante, diventando la «scrofa sacrificale» di una cannibalistica cena di San Valentino. Si prosegue, infilando il sentiero – non nuovo per il fantastico orientale – dei minima et moralia con una miniraccolta di cinque racconti, Spiriti leggiadri, firmati da Inoue Masahiko, dove le dimensioni tra i mondi sfumano sino all'inconsistenza: in Quattro ore e quarantaquattro minuti ecco l'identità, tutta orientale, tra leggenda metropolitana e racconto di spiriti (nel fantastico occidentale le cose stanno diversamente: le due categorie non sono affatto coincidenti, l'una appartenendo al fantastico popolare di trasmissione orale e l'altro al gotico letterario) e il tassista che accoglie sulla sua macchina clienti che gli raccontano urban legends diventa lui stesso protagonista di una leggenda metropolitana; quindi il sogno di un moribondo, ovvero un gigantesco acquario per tutti i morti affogati del mondo ne Il racconto del sogno d'acqua, dimensione evanescente che viene clamorosamente smentita dal successivo Il fascino dei geta (i geta sono caratteristici zoccoli di legno), terrificante e geniale racconto dove un demone perverso attira vittime sulle strada ferrata per appropriarsi dei geta con tanto di gamba attaccata (ma alla giovane protagonista, sfortunata di turno, stavolta il demone riesce a fare un trattamento particolare, lasciandole le gambe, o quasi…); ma ecco che l'impalpabilità di Masahiko torna a padroneggiare con Stelle di mare, in cui avviene una delle infestazioni più diabolicamente originali della letteratura fantastica, quella di un albergo invaso da stelle marine, e con I parasole, dove un gruppo di morti viventi vaga tra le dimensioni, ognuno portando come una carta d'identità personale un parasole di colore diverso.
Sarà un caso che nell'anno in cui il mercato italiano pare riconfermare la scoperta, con l'arrivo del secondo romanzo di Suzuki Kôji Spiral, delle storie nipponiche di spettri, un cospicuo spazio di Alia sia proprio dedicato a un gruppo di autori che sull'inquietante mondo degli ectoplasmi con occhi a mandorla vuole capitalizzare in modo intelligente e sinceramente perturbante? Scontata la risposta, non è un caso, perché – già lo enunciavamo lo scorso anno – l'Oriente fantastico è più che mai di tendenza e poco importa se il grande successo multimediatico di Ring (film, libro e comic) si porti dietro un po' di tutto (lo stesso Spiral è meno amabile del sequel alternativo, più intrigante e meno pedante, predisposto dal regista Nakata e dallo sceneggiatore Takahashi Hiroshi nel film Ring 2), perché il mondo dei kaidan è veramente unico e Alia è qui, anche, per dimostrarlo. La sua unicità è infatti, per paradosso, la sua estrema versatilità: nel senso che ogni autore sembra perseguire una via del tutto esclusiva, senza che sia visibile una sola coordinata in comune con un proprio affine o «vicino di casa». Prendete per esempio Asagure Mitsufumi (L'uomo con il capello e Oyakushisama), il cui senso antiretorico e il minimalismo surreale riescono a relegare in secondo piano il dato che «comunque qui di fantasmi si parla», giungendo a fornirci con il secondo titolo un racconto destrutturato temporalmente da leggersi più volte, seguendo le istruzioni dell'autore sulla disposizione funzionale dei singoli capitoli. Prendete lui e paragonatelo, se vi fosse possibile, a quella sorta di Richard Matheson orientale che è Hayami Yûji, presente con tre titoli, uno più efficace dell'altro, dove le peculiarità del genere sono sì riconoscibili per quanto originalmente declinate: da Notte sul vagone letto, un inconsueto e raggelante horror express la cui soluzione ricorda non poco – ma con assoluta causalità – la bellissima cornice nonché il finale de Le cinque chiavi del terrore, film di Freddie Francis del 1964, passando attraverso il surreale Fumo sottile, in cui scopriamo che è possibile sposarsi con una zanzara e per fortuna restarne in fretta vedovi (non mancando di avere provato quel brivido di alterità che ti coglieva dopo avere letto La mosca di George Langelaan), e giungere a un autentico incubo metropolitano, Rumore di passi, che dimostra che certe paure sono del tutto analoghe in ogni parte del mondo. Nel racconto di Iino Fumihiko Colpo di fulmine invece il terrore cambia talmente registro che sembra aleggiarvi quel surrealismo caro al Gruppo Panico degli Arrabal e dei Jodorowski: da un punto di vista quanto mai particolare (un io narrante che è il fantasma di un suicida – ma lo sapremo soltanto verso la fine…), quello di chi s'innamora a prima vista di una ragazza molto bella che sta entrando in un albergo assai particolare, scopriremo tra autentici tocchi/schizzi di splatter intollerabile che la poveretta andrà a subire una sorte terrificante, diventando la «scrofa sacrificale» di una cannibalistica cena di San Valentino. Si prosegue, infilando il sentiero – non nuovo per il fantastico orientale – dei minima et moralia con una miniraccolta di cinque racconti, Spiriti leggiadri, firmati da Inoue Masahiko, dove le dimensioni tra i mondi sfumano sino all'inconsistenza: in Quattro ore e quarantaquattro minuti ecco l'identità, tutta orientale, tra leggenda metropolitana e racconto di spiriti (nel fantastico occidentale le cose stanno diversamente: le due categorie non sono affatto coincidenti, l'una appartenendo al fantastico popolare di trasmissione orale e l'altro al gotico letterario) e il tassista che accoglie sulla sua macchina clienti che gli raccontano urban legends diventa lui stesso protagonista di una leggenda metropolitana; quindi il sogno di un moribondo, ovvero un gigantesco acquario per tutti i morti affogati del mondo ne Il racconto del sogno d'acqua, dimensione evanescente che viene clamorosamente smentita dal successivo Il fascino dei geta (i geta sono caratteristici zoccoli di legno), terrificante e geniale racconto dove un demone perverso attira vittime sulle strada ferrata per appropriarsi dei geta con tanto di gamba attaccata (ma alla giovane protagonista, sfortunata di turno, stavolta il demone riesce a fare un trattamento particolare, lasciandole le gambe, o quasi…); ma ecco che l'impalpabilità di Masahiko torna a padroneggiare con Stelle di mare, in cui avviene una delle infestazioni più diabolicamente originali della letteratura fantastica, quella di un albergo invaso da stelle marine, e con I parasole, dove un gruppo di morti viventi vaga tra le dimensioni, ognuno portando come una carta d'identità personale un parasole di colore diverso.
Con Opus Magnum di Shinoda Mayumi il «genere» poi assume addirittura una singolare peculiarità «casalinga», perché si tratta di un racconto medioevale ambientato in Italia, una sorta di versione stregonesco-alchemica sulla vita, le opere e la morte di Leonardo Da Vinci, che secondo l'autrice sarebbe stato nientemeno che un homunculus fabbricato da una strega con sperma umano e altri ingredienti all'uopo. Con gli ultimi due autori della tornata giapponese (Tsuhara Yasumi e ôta Tadashi) approdiamo in qualche modo su lidi più riconoscibili e battuti anche dal gotico internazionale. Con Aquapolis e La promessa Yasumi ci ricorda che sovente le ghost stories sono anche e soprattutto storie d'amore: la prima è una vicenda d'infanzia crudele, collegata a un elemento quanto mai catalizzatore nel fantastico nipponico, ovvero l'acqua, mentre nella seconda – con una bizzarro richiamo al famoso film di Zucker Ghost – un ragazzo fa una promessa d'amore a una sua coetanea, morendo purtroppo poche ore dopo, e vegliando su di lei nella nuova condizione di fantasma per tutta la durata della sua vita fisica; scoprirà, quando lei morirà di vecchiaia, che la donna si era accorta della sua presenza, preservando il segreto nel suo cuore a suggello della promessa fatta e mantenuta. Con ôta Tadashi (La casa di vetro e Symbol Tree) sembra infine di rivivere angosce e ossessioni care a un certo New England e rivisitate negli anni Sessanta al cinema dall'indimenticabile Milton Subotsky della Amicus: se nel primo la più infantile e la più inquietante delle paure, il labirinto di vetro, diventa metafora della vita e della morte, nel secondo una misteriosa pianta «vivente» compie la più incredibile delle vendette su un proprietario di casa che ha scacciato un vecchio dall'abitazione in cui ha vissuto per anni. Degno seguace della «strana pianta rampicante» del già citato cult Le cinque chiavi del terrore di Freddie Francis, omaggiato anche di recente da Sergio Stivaletti ne I tre volti del terrore.
Con il Giappone avremmo finito, ma il resto della portata è ancora ottimo, abbondante e variegato. Fantascienza, horror e fantastico allo stato puro sono i binari su cui viaggia la compagine italiana. E se abbiamo usato il condizionale con «avremmo finito», non è un caso, perché mi piace partire proprio con i due autori che, oltre a essere tra i numi tutelari dell'operazione Alia, sono coloro che si presentano con «l'Oriente dentro» con altrettanti racconti che al Sol Levante guardano, tanto al passato che al futuro, convinti come sono – e forse hanno ragione – che laggiù ci sono parecchie ragioni per capire dove sta andando il nostro ammaccato pianeta. Sono Massimo Soumaré con Il magatama e Davide Mana con Ombre elettriche, due modi quanto mai originali di declinare il mai troppo sviscerato tema del fantasma. E al futuro guarda ancora, con paura e ammonimenti, la fantascienza sociologica di Catani, Ragone, Cola, Pederiali, Burgio e Citi, ognuno di loro sorprendente per trovate e idee geniali che vanno giustamente menzionate. Catani che, con La tarda estate, costruisce una commovente elegia del passato inteso quale sola «via di fuga» nei riguardi di un presente devastante; un lucido e spettacolare Eugenio Ragone, Il canto delle sirene, sulle orme del «Solitario», un fuggiasco geneticamente manipolato che, braccato dopo essere stato creato in laboratorio, riduce all'impotenza i suoi inseguitori con una sorta di «canto delle sirene» mentale; il raggelante Alberto Cola che con Bocca di vetro ci proietta in un futuro dietro l'angolo dove l'Apocalisse bellica (chi combatte contro chi? Non è una situazione poi così lontana dall'oggi…) riduce un brandello di umanità allo sbando più totale; Pederiali con un racconto kafkiano, L'esenzione, che riprende un tema non nuovo nella fantascienza distopica, quello della morte programmata – un po' alla Fuga di Logan – per rimediare per quanto possibile al problema del sovraffollamento planetario; Misterika di Giuseppe Burgio, racconto fantafilosofico che propone un futuro «antichizzato» dove il destino dell'uomo è segnato da impressionanti rituali che sono esperimenti simbiotici tra uomini e organismi vegetali, e Specchiofumo del geniale Massimo Citi, dove sopra un pianeta artificiale di apparente «gelatina» (la cosiddetta «iperacqua» dentro la quale i morti vengono sepolti e le loro silhouette sono visibili dall'esterno, incutendo terrore nei visitatori) si consuma l'eterno dramma delle «diversità» della società multietnica.
Della compagine italiana altri quattro autori sono di sicuro meno inquadrabili nella «griglia» del genere. Consolata Lanza, che per sua medesima definizione «si occupa di fantasticheria applicata alla realtà» (ha scritto Il gioco della masca e A est di Cipango), diverte e stupisce con Di un'apparizione mariana alla Mole Antonelliana di Torino, ironico ritratto di una Torino futuribile e caotica dove appaiono quattro Madonne sulle altrettante facciate della Mole con effetti grotteschi e surreali. Silvia Treves con Bambola carboncino ci regala una preziosa metafora post-moderna sull'incomunicabilità laddove persino lo stesso Avatar della rete può divenire un fantasma. E lascio per ultimi due amici, così non mi si accusa di parzialità per quanto li ami come autori in modo poco imparziale: la ghost-story Vento dal mare di Vittorio Curtoni, che cela sotto il simulacro del fantasma che torna dall'aldilà marittimo il rimpianto del passato e del tempo che trascorre (un finale superbo e agghiacciante – perché mai, Vittorio, non hai mai calcato seriamente le strade dell'horror?), e la riconferma – qualora ne sentissimo la necessità – di Alessandro Defilippi che con La dama nera ci proietta in un Piemonte contemporaneo, gotico e nebbioso, e un racconto tutto basato, ancora, su quella esitazione alla Todorov che crea l'effetto fantastico, a favore di una sfuggente figura femminile, al contempo un fiore, una donna da amare e la Morte che accompagna come Caronte un uomo condannato da un male incurabile.
«Curiose» e di assoluto valore, alla fine, le presenze anglosassoni. Da un passato da recuperare, ecco La figlia di Satana di E. Hoffman Price, con un quanto mai familiare inizio in puro archeological horror (potrebbe persino essere L'esorcista di Blatty) dove un archeologo tira fuori dalle sabbie dell'Iraq la statuina di Bint el Hareth, letteralmente «la figlia di Satana». Il demone-femmina si materializza dalle sabbie e conduce il protagonista, Morton Reed, lungo le spire di un incubo erotico che attraversa scenari avventurosi pre-Indiana Jones. Quindi I Vermi della terra di Robert E. Howard, ambientato in un'immaginaria colonia dell'antica Roma, dove le truppe dei conquistatori italici colonizzano ferocemente la popolazione dei pitti e re Bran, degno protagonista di un incubo alla Lovecraft, ridesta i membri parassitiformi di una razza antichissima per distruggere gli invasori. La satira fantaerotica di Marc Don Giovanni su Marte, una «seconda puntata» di un'ipotetica serie, in cui due protagonisti in preda alle delizie dell'Eros vivono come Tarzan e Jane braccati mentalmente da misteriosi marziani telepatici. Un singolare contributo di «falso fantastico», Lo spiritista (dove gli effetti irreali sono dovuti a una truffa ordita da un impostore che lucra sul paranormale), dovuto alla penna brillante di Rafael Sabatini, scrittore nato a Iesi nel 1875 e morto nel 1950 in Svizzera, autore di romanzi avventurosi a sfondo storico (Capitan Blood, Il cigno nero e Scaramouche) che ebbero un enorme successo di pubblico grazie anche a mitiche versioni cinematografiche. Il curiosissimo e anticipatore La città dei morti viventi, proveniente dalle famose Science Wonder Stories di Hugo Gernsback, racconto del 1930 scritto a quattro mani da Murray Fletcher Pratt e Laurence Manning che è un clamoroso esempio di proto-cyberpunk dove le macchine simulano una realtà artificiale. E due vere gemme al termine di questo nostro excursus: un'autrice sconosciuta e inedita in Italia, Olivia Howard Dunbar, nata nel Massachussets nel 1873 e morta nel 1953 a New York, che sulle orme delle storie di fantasmi alla Shirley Jackson e alla Edith Wharton, disegna una stanza degli ospiti (La Stanza Lunga) che conserva l'essenza spettrale di un tragico amore del passato, e il contemporaneo David Farnell che nello spaventoso Tigre ambienta in un Vietnam allucinato, degno del Koko di Peter Straub, la storia di un ragazzo occidentale allevato da uno stregone che diventa un demone con poteri soprannaturali ed emigra in America allo scopo di «inglobare in sé» altre vittime. Un'ulteriore metafora in salsa horror sulla ferita vietnamita mai rimarginata che deve farci meditare su quanto sta accadendo in un'altra zona del mondo dove la «guerra esportata» sta raggiungendo inimmaginabili livelli di ferocia.
Se siete sin qui sopravvissuti (ma, se vi trovate qui, è perché avete presumibilmente letto tutti i racconti – o quasi – di Alia), ora siete in attesa della famosa chiusura che tira le fila dei tanti discorsi fra le righe. Non sono poche le (provvisorie) conclusioni che si potrebbero produrre a monte di un'antologia così variegata e nutrita. Ma, dopo quasi 14.000 battute, qualcuno potrebbe a ragione mandarmi al diavolo. Allora ne scelgo una, quella a mio parere più importante. Che cosa tiene assieme tanti racconti di contesti culturali e temporali così diversi? È qui, non a caso, sotto i nostri occhi. È la visione, anzi un errore prospettico della medesima: chiamatela allucinazione, fantasma, cyberspace ante litteram, buco nel reale od «occhio che uccide». Alla fine è qualcosa che s'insinua tra ciò che ci appare e ciò che il cervello elabora. Un intruso nel nostro visibile quotidiano. Ancora una volta, la lezione del Giro di vite: chi vede cosa, e chi racconta di queste esperienze dis-percettive. Non è una singolare allegoria del nostro attuale rapporto allucinatorio con i media? Non è la riconferma, una fra le tante, che di questi fantasmi di carta abbiamo sempre più necessità per capire la realtà simulacrale che stiamo vivendo?
Risposta scontata, ancora una volta. Perché, come scrisse Alexander Lernet-Holenia, «la vita comincia a diventare interessante soltanto nei momenti in cui diventa irreale, e i racconti più perfetti sono quelli che, potendo rivendicare la massima verosimiglianza, raggiungono il massimo grado d'irrealtà».
1) Rubo indegnamente il titolo di questa postfazione a un bel libro di Massimo Romano, pubblicato da Studio Tesi nel 1986, quanto mai da riscoprire.